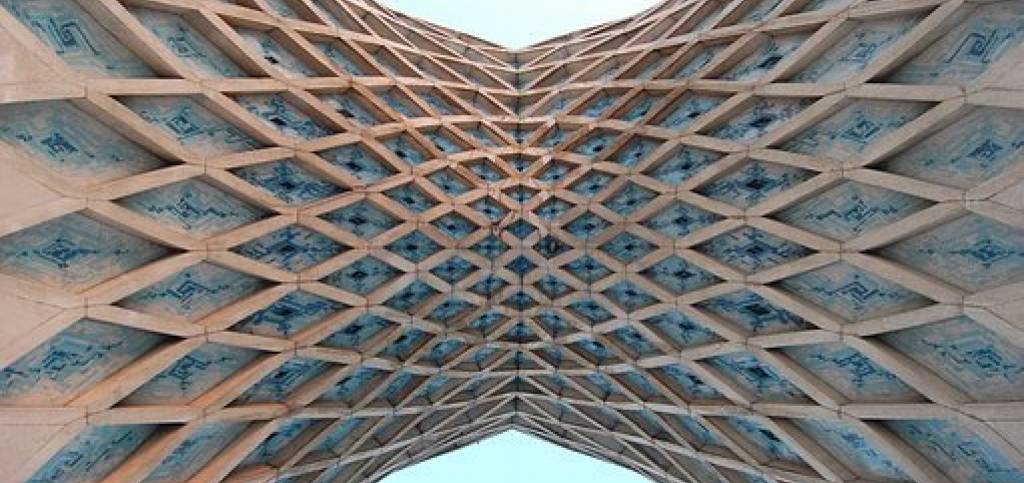
Verso nuove sanzioni statunitensi sull’Iran?
25 settembre 2020
L’amministrazione Trump, che nel 2018 aveva stracciato l’accordo sul nucleare del 2015, propone sanzioni a Teheran basate su quell’accordo. Intervista con Nicola Pedde (IGS)
Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, l’amministrazione Trump mostra una politica sempre più aggressiva nei confronti dei suoi storici avversari e nemici. Nei giorni scorsi, in particolare, il Segretario di Stato, Mike Pompeo, ha invitato il Vaticano a non rinnovare l'accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi, stipulato nel 2018, sostenendo che «l’abuso del Partito comunista cinese sui fedeli è solo peggiorato» e che «il Vaticano metterebbe a rischio la sua autorità morale, se rinnovasse l'accordo». Si tratta di un’iniziativa pensata per mettere sotto pressione la Cina su uno degli aspetti su cui è più vulnerabile di fronte all’opinione pubblica internazionale, ovvero i diritti umani e il rispetto delle minoranze, che siano etniche o religiose.
Tuttavia, l’iniziativa nei confronti del Vaticano non è l’unica portata avanti in questi giorni: lo scorso fine settimana, infatti, Washington ha dichiarato che le sanzioni economiche multilaterali previste dall’accordo sul nucleare (Jcpoa) firmato nel 2015 dall’Iran, i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti) più la Germania e l’Unione europea, sono in vigore e devono essere rispettate in tutto il mondo.
Quelle sanzioni, istituite dalle Nazioni Unite, erano state congelate proprio per facilitare la firma dell’accordo. Inoltre, gli Stati Uniti erano usciti dal Jcpoa nel 2018, ritenendolo violato pur in assenza di prove.
La presa di posizione di Washington rinnova la cosiddetta “strategia della massima pressione” perseguita nei confronti di Teheran nel corso di tutto il mandato dell’amministrazione Trump, ma è stata respinta dagli altri Paesi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che non riconosce la capacità giuridica statunitense su questo tema.
Nicola Pedde, direttore dell’Institute for Global Studies, spiega che «gli Stati Uniti ritengono gi avere la capacità di intervenire nel processo in quanto ex appartenenti alla compagine che ha definito l'accordo, anche se giuridicamente questo valore, per quanto concerne gli altri componenti superstiti dell'accordo, non esiste. Inoltre fanno riferimento a un provvedimento legislativo interno all'amministrazione americana, cioè quello che due mesi prima della firma del JCPOA regolava di fatto i poteri dell'amministrazione americana in relazione all'adesione dell'accordo e soprattutto prevedeva ulteriori ambiti potenzialmente oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti. Anche questo, chiaramente, non trova riscontro nella applicabilità da parte degli altri Paesi del Consiglio di Sicurezza dell'Onu o comunque firmatari dell'accordo».
Questi Paesi ritengono che la presa di posizione degli Stati Uniti sia priva di effetto. Se questo è vero sul piano giuridico, si può dire lo stesso su quello pratico?
«In teoria sì, ma la pratica è ben diversa: sfidare gli Stati Uniti su un provvedimento del genere vuol dire entrare in una dinamica di relazioni critiche, soprattutto sul piano economico, con gli Stati Uniti. Questo chiaramente scoraggia e spaventa molti attori politici e soprattutto economici all'interno della dimensione quantomeno bilaterale dei rapporti tra Europa e Stati Uniti».
Come sono state accolte queste dichiarazioni a Teheran?
«Gli iraniani sono molto divisi sull'argomento, nel senso che anche all'interno del sistema politico iraniano ci sono posizioni molto confliggenti sul Jcpoa e non manca, anche all'interno della Repubblica islamica, una componente che vorrebbe veder crollare definitivamente questo accordo che ritiene ingiusto e gestito male rispetto agli interessi del Paese. Dall'altra parte c'è il governo Rouhani, che cerca invece in ogni modo di salvare il salvabile di questo accordo e che cerca di non entrare in una dimensione di crisi totale con gli Stati Uniti. Per farlo, prova a fare pressioni sugli europei per poter continuare a godere dell'efficacia di questo accordo. Il problema è che l’efficacia manca sul piano sostanziale, perché il Jcpoa è valido per gli europei sulla carta, ma nel pratico rimane impossibile fare transazioni finanziarie, se non piccole cose, a causa del blocco completo del sistema bancario e finanziario che, sotto pressione americana, non dà alcun supporto alla dimensione economico-finanziaria delle relazioni con l'Iran».
Questo è un problema che riguarda anche altri scenari. Pensiamo anche al Caesar Act votato nel 2020 dal Congresso degli Stati Uniti per danneggiare le persone al vertice della politica siriana: quella legge contribuisce a bloccare anche le operazioni della cooperazione internazionale, compresa quella italiana, nel Paese.
Da un punto di vista regionale, il rinnovo della “massima pressione” sull’Iran arriva subito dopo la firma del cosiddetto “Patto di Abramo” tra Israele e alcune monarchie del Golfo, con cui i rapporti si stanno distendendo. Anche questo processo va interpretato in chiave anti-iraniana?
«Diciamo che l’accordo raggiunto da Emirati Arabi Uniti e Bahrein insieme a Israele ha una forte nature securitaria. Da un lato, Israele è alla ricerca di una legittimazione regionale da parte di alcuni Paesi arabi e vuole formalizzare una cooperazione sul piano militare e di intelligence che in realtà è già presente da molto tempo tra i due Paesi. Dall'altro, il problema è che questo rapporto è costruito su una natura anti-iraniana. Il problema vero non è solo il fatto di aver costruito un'alleanza che è tutto sommato priva di ulteriori elementi se non quelli di ostilità verso un altro attore regionale. Il problema è che manca completamente la fiducia tra gli attori che hanno firmato l'accordo. All’inizio della settimana il ministro della Difesa israeliano, Binyamin Gantz, è volato a Washington proprio per esercitare la massima pressione politica possibile per impedire che gli Emirati Arabi Uniti, i firmatari principali di quell'accordo, possano acquistare gli F35. Abu Dhabi vorrebbe, all'interno di questo accordo, riuscire a ottenere un ingresso nella maglia di sicurezza regionale gestita da Stati Uniti e Israele, ma il loro principale alleato e firmatario, ovvero proprio Israele, non si fida e vorrebbe impedire la vendita di questi sofisticati aerei. Da qui partono una serie di ipotesi che si stanno facendo in questi giorni, cioè dare aerei con minori tecnologie ed equipaggiamenti a bordo, o addirittura farli con una lega di metallo diversa rispetto a quella che permette la capacità stealth. Insomma, è un accordo che ha diversi problemi sul piano sostanziale».
Se l'Iran volesse provare ad avere un supporto più concreto da parte dei Paasi che ancora fanno parte del Jcpoa, che cosa potrebbe offrire in cambio?
«L'Iran ha già firmato nel 2015 un accordo che offre molto e che è stato rispettato pienamente. Il problema è che alla firma di questo accordo è stata accompagnata una contestuale richiesta da parte anche dei principali attori europei di ulteriori concessioni da parte dell'Iran, soprattutto sul programma missilistico e sulla politica regionale. Questo era stato interpretato dall'Iran come un tradimento dello spirito dell'accordo. Credo che oggi ci siano i margini per poter negoziare con l'Iran un più vasto vasto ambito di cooperazione, il problema è che sta venendo meno progressivamente la fiducia da parte di tutti gli attori, in particolare degli iraniani, che dal loro punto di vista vedono che qualsiasi cosa venga firmato con i paesi occidentali viene immediatamente ritrattato con nuove richieste e nuove posizioni negoziali».
