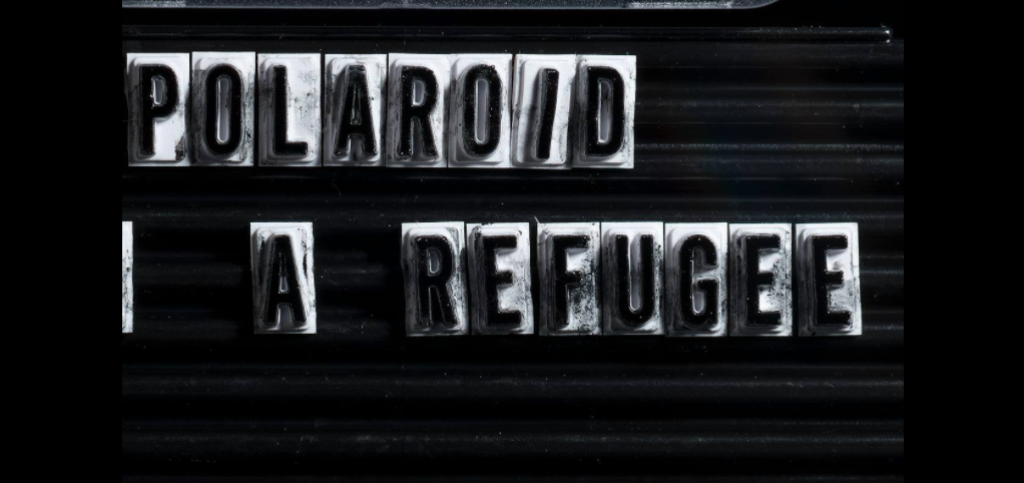
A polaroid for a refugee
23 febbraio 2017
Due scatti: uno per chi è in viaggio e uno per la fotografa. Un progetto umanitario che è anche una mostra fotografica dedicata ai migranti
Giovanna Del Sarto è una fotografa, potremmo anche definirla un'emigrata per motivi economici. Ce ne sono molti a Londra e lei è una di loro. Nel 2015 ha deciso di partire per seguire un impulso, forse di rabbia, o di curiosità. Cosa stava succedendo ai confini dell'Europa dove si ammassano i rifugiati provenienti dall'Afghanistan, dal Pakistan o dalla Siria? Attraverso i media passa sempre una minima parte di informazioni, condita da molte sciocchezze e razzismo. Lei non è un'ascoltatrice accondiscendente, così ha preso due macchine fotografiche, una era una Polaroid Land Camera, ed è partita per andare a vedere coi suoi occhi.
Il risultato è un'esposizione che sarà fino al 9 marzo presso WSP photography, in via Costanzo Cloro a Roma.
Com'è iniziato il viaggio?
«La prima tappa che ho fatto è stata Preševo in Serbia dove ho cominciato a lavorare metà tempo come volontaria per le piccole associazioni e l'altra metà facendo fotografie. Con la Polaroid, in varie situazioni e a diversi rifugiati, ho fatto dei ritratti per regalarli a loro. "A polaroid for a refugee" non è altro che questo, un progetto per le persone. Ho chiesto di poter fare due foto, una per loro e l'altra per me, da riportare a Londra per far vedere cosa ho vissuto e le persone che in questo momento stanno vivendo in una situazione tanto difficile»
Quindi il vero soggetto in mostra non sono le fotografie, ma le persone?
«Ho messo la fotografie in secondo piano perché cercavo un contatto diverso con gli uomini e le donne che hanno lasciato tutto per cercare, anche per poco tempo, una vita migliore fino a quando non sarà possibile tornare nel loro paese, magari grazie a una tregua. Ci sono mamme con bambini piccoli che mi hanno chiesto di fotografarli facendomi capire che avrebbero tenuto la foto fino a quando il bambino sarebbe cresciuto, tutti mi hanno ringraziata per questo piccolo regalo. In effetti io sono partita con l'idea molto romantica che potessero tenere questa polaroid per sempre, che possano riguardarla in futuro e magari ricordarsi di un momento difficile che poi è migliorato, o magari per constatare che nulla è cambiato».
Come ha reagito chi ha visto il progetto?
«La prima parte del progetto consisteva nel consegnare la prima polaroid ai rifugiati, quindi sono loro i primi spettatori. Posare, scattare la foto e aspettare insieme quei due minuti che l'immagine apparisse si trasformava in un momento di gioia.
Quando sono tornata e ho cominciato a fare mostre e a pubblicare il mio lavoro, quello che vedevo negli spettatori era una specie di gratitudine, quella di trovarsi di fronte a immagini diverse da quelle che si trovano nei giornali. Tutti noi, esseri umani, possiamo toccare il fondo per vari motivi, ma quando lo facciamo quasi sempre troviamo una forza interna che ci fa reagire e tornare a galla così da poter trovare la forza di combattere. Queste persone sono tornate a galla, nelle fotografie sorridono; nelle polaroid c'è il sorriso di siriani, afghani, pakistani che hanno fatto questo viaggio della speranza».
Cos'è che l'informazione proprio sbaglia rispetto alla situazione dei profughi e dei rifugiati e che l'ha spinta a partire?
Io posso solo dire il mio punto di vista. Una cosa che mi ha fatta partire è stato sentire troppe volte, anche da persone emigrate come me, il lamento e il disagio rispetto all'arrivo dei rifugiati, così come mi mette a disagio la credenza che l'Europa possa diventare musulmana a causa dei profughi e cambiare. Sappiamo che non è possibile così come sappiamo che chi arriva non è un terrorista per forza. Per questo sono partita e quello ho trovato sono famiglie come quella di qualsiasi di noi; poteva toccare a noi, essere noi italiani che a causa della guerra avremmo dovuto rifugiarci in Siria»
Quali sono le storie dietro queste immagini?
«Ce ne sono tante. Quando era possibile, dopo aver dato la polaroid, lasciavo la mia mail o il numero di telefono e chiedevo se, una volta arrivati a destinazione, potevano contattarmi, per sapere se stavano bene. Fra tutti quelli che ho fotografato, quattro persone l'hanno fatto.
Ho particolarmente a cuore la storia di una famiglia siriana: l'anno scorso sono stata nel campo di Idomeni, la prima notte non avevo un posto dove dormire, con il mio sacco a pelo ho pensato di chiedere a una famiglia siriana, composta dalla madre con sei bambini, di poter dormire nella loro tenda; lei ha detto di si quindi sono stata con lei per due giorni. La sua destinazione era la Germania, vicino a Francoforte dove il marito era lì che l'aspettava, però lei è arrivata con qualche giorno di ritardo perché la frontiera macedone era già chiusa quindi è rimasta nel campo fino a che non è stata evacuata. Il giorno dell'evacuazione del campo di Idomeni lei era riuscita a passare la frontiera, aveva scritto dicendomi che era in Macedonia però poi l'avevano riportata in Grecia. Dopo quel messaggio non ho più sentito nulla. L'anno scorso a dicembre mi è arrivata una fotografia tramite Whatsapp delle due polaroid che avevo regalato, distrutte e sporche perché avevano vissuto il viaggio; poi un messaggio scritto che diceva “Sono arrivata in Germania, sono con mio marito”».
